Il suo nome, la COP21, lo eredita dai suoi 20anni precedenti e dall’aver scelto Parigi per la sua 21esima edizione. [1]
21esima quindi, cio’ significa che si sono abituati a discuterne. E se a questo aggiungessimo tutti i dibattiti delle COP da oggi a 20 anni fa, corrisponderebbe a più di un anno di tempo.
Tra tutte queste interminabili discussioni, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi si vuole pero decisiva e la campagna di comunicazione che l’accompagna cerca di esserne all’altezza. In seguito al fallimento di quella di Copenaghen del 2009, quella di Parigi dovrà portare ad un nuovo accordo internazionale, per dare seguito al protocollo di Kyoto, senza ripercorrerne i fallimenti, dicono.
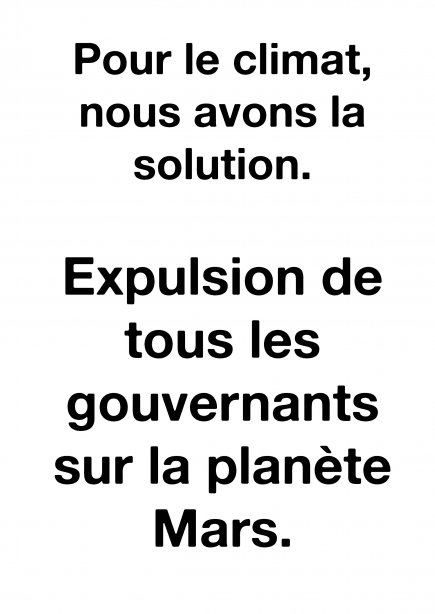
« Per il clima, abbiamo la soluzione. Espulsione di tutti i governatori sul pianeta Marte. »
La spartizione del fardello, una responsabilità comune ma differenziata
L’implicazione umana é oggi stabilita e riconosciuta "scientificamente", la sua colpevolezza rispetto all’inquinamento é ormai ampiamente validata. Precedentemente, sino alle prime COP (a partire dal 1995), il dibattito verteva sulla proporzione tra le variazioni climatiche "naturali" e quelle attribuibile all’intervento umano, purché molti rifiutassero l’ammissione del ruolo dell’essere umano sulla questione. Le dispute oggi non si giocano più su tale negazione del problema, ma sulla spartizione del fardello. Una volta pronunciata la parola "umano", ognuno vuole riempirla a modo suo.
Tutta la posta in gioco é dunque quella di riuscire ad intendersi. Gli uni, potenti ben stabili, chiamano agli sforzi du tutti, gli altri esigono il diritto allo sviluppo e soprattutto a un’altra divisione delle responsabilità, rispetto a quella di una spartizione attorno alla stessa tavola in cui tutti avrebbero sporcato i piatti allo stesso modo. Per le grandi potenze, si tratta di una preoccupazione comune su scala mondiale. Gli altri, anche a giusto titolo, rivendicano piuttosto una « responsabilità storica comune ma differenziata ».
Attualmente, la principale frattura all’interno della COP traccia per cui la divisione tra le grandi potenze del nord e i paesi detti "in via di sviluppo", chiamati più recentemente "paesi emergenti" (secondo le terminologie della COP). I potenti continuano a voler dettare la loro versione della storia e le loro prerogative senza alcuna costrizione. Gli altri cercano di far riconoscere quanto sia difficile pretendere sia di parlare a nome di una qualsivoglia uguaglianza, che di dichiarare la stessa responsabilità della catastrofe presente rispetto al passato. Nell’insieme, si cerca un equilibrio attraverso l’adozione di cifre di riduzione delle emissioni di CO2 e di vaghi obiettivi di stabilizzazione. Tutti si accordano soltanto su un punto : la necessità di mai più oltrepassare le sovranità nazionali.

« Il riscaldamento globale ? Sono ormai secoli che ci fate infuocare le orecchie... »
« Ridurre l’inquinamento del carbone in uscita »
Il grande momento della strategia COP é stato il protocollo di Kyoto, stipulato nel 1997 e entrato in vigore nel 2005, dopo che 175 paesi (ma non gli Stati Uniti) l’avessero rettificato. Fondamentalmente, la questione climatica é pensata parallelamente alla riduzione dello strato di ozono, ovvero come se si trattasse di problema ambientale legato esclusivamente all’inquinamento del carbone. Il problema ecologico rileverebbe soltanto dall’inquinamento, per cui farebbero oggetto del dibattito esclusivamente i tassi di riduzione delle emissioni di CO2 in uscita.
« Il Protocollo prevede degli obiettivi di emissioni differenziate secondo il livello di sviluppo e la forza di negoziazione dei paesi : -8% per l’Unione Europea, -7% per gli Stati Uniti, -6% per il Giappone, una stabilizzazione per l’Ucraina e la Russia, mentre invece Australia e Islanda hanno diritto a aumentare le loro emissioni moderatamente. Tali riduzioni si accumulano al -5,2% per i paesi sviluppati e le economie di transizione (ovvero i paesi del vecchio blocco sovietico), repertoriati nell’allegato B del protocollo. Tali riduzioni sono calcolate rispetto al livello di un anno - il 1990 - e devono essere raggiunte durante il periodo che va dal 2008 al 2012. »
Tuttavia, la definizione d’inquinamento non soddisfa gli americani che rifiutano l’accordo, « il nostro stile di vita non é negoziabile » afferma Bush. Tale reazione deriva principalmente dal fatto che la Cina, considerato come paese "in via di sviluppo", non é sottomessa alle stesse restrizioni. I paesi "in via di sviluppo" hanno dunque da allora come criterio non negoziabile la ratifica americana, affinché possa essere imposta qualsiasi obbligazione internazionale. In ogni modo, poco importa. Il protocollo di Kyoto, é per tutti un fallimento, le misure non sono seguite, numerosi paesi l’hanno da parecchio tempo abbandonato.
Per quanto riguarda il mercato, il che funziona per l’economia ma non per il clima, il protocollo creava il "mercato carbone" attraverso il quale poter vendere il "diritto d’inquinare". Sul mercato, all’inizio creato per incitare alla riduzione di emissioni CO2 facendo pagare all’emettente il costo delle nocività ambientali, é possibile acquistare su richiesta i diritti di inquinamento, scambiando i diritti di emissioni di gas a effetto serra contro qualche pala eolica se necessario.
Dopo Kyoto, altri tentativi di protocollo non hanno di certo meglio riuscito. L’ultima data Copenaghen nel 2009 :
« Per alcuni, fare di Copenaghen un’appuntamento cruciale doveva avere degli effetti positivi : rafforzare la coscienza del rischio climatico sulla scala mondiale, riunire un numero impressionante di dirigenti del mondo in un periodo fortemente strategico e favorizzare la mobilitazione internazionale della società civile. Tuttavia, tale macchinario a mostrato molti aspetti negativi e il sentimento di fallimento che a seguito é stato ancor più clamoroso e paralizzante. »
« Il solo risultato tangibile della conferenza é un testo riduttivo, detto "l’accordo di Copenaghen", nel quale una trentina di paesi - ovvero quelli che rappresentato l’80% delle emissioni mondiali - riconoscono che il cambiamento climatico é una delle grandi sfide dei nostri tempi e esige una forte volontà politica per evitare di oltrepassare la barriera dei 2°C, giudicata pericolosa dagli scientifici. L’accordo riporta ufficialmente, e per la prima volta, l’accettazione dalla parte degli Stati Uniti e dei « paesi emergenti » di ridurre le loro emissioni, tuttavia alcun impegno calcolabile sugli obiettivi di riduzione, alcun meccanismo vincolante o alcuna misura di verificazione é menzionata nel testo. Alcun orizzonte temporale é assegnato alla barriera dei 2°C. Un certo numero di elementi sul finanziamento dell’adattamento nei paesi in via di sviluppo sono enunciati. »
« Gli Stati sono stati condotti a prendere degli impegni volontari di riduzioni delle emissioni nel 2020, ma senza alcuna prospettiva di regolamentazione. Riduzioni, quindi, che rischiano di essere incomparabili, non verificabili, non vincolanti e reversibili in ogni momento. »
Le discussioni, tanto per il protocollo di Kyoto che per ogni COP, portano esclusivamente sull’emissione di CO2 in uscita, senza alcuna costrizione alla base che verterebbe ad esempio sulla limitazione dell’estrazione petrolifera o mineraria, o sulle stesse modalità di produzione. Tale centralità delle emissioni di CO2 favorizza ad esempio la presentazione del nucleare come un « energia verde », poiché alla fine poco CO2 viene emesso dai reattori…
Una Parigi diplomatica

« L’era glaciale é immediata per tutte le forze di Polizia. Salviamo il clima ! »
In seguito al fallimento di Copenaghen, é la COP21 a Durban (Sud Africa) ad aver lanciato un nuovo processo di negoziazione per arrivare a un nuovo accordo internazionale nel 2015.
Kyoto ha fallito e il mondo é cambiato. Se altro non fu che una finzione a fini utili, la divisione Nord/Sud, grandi potenze/paesi in via di sviluppo, tale é che non funziona più per descrivere lo stato dei rapporti di forza attuali su scala mondiale. L’India, il Brasile e la Cina ad esempio, non sono più quantificabili come « potenze emergenti » senza che cio’ sembri derisorio, come dichiaravano altri membri dell’ONU.
Le discussioni prederanno dunque tutt’altra forma. L’Europa spera sempre di giocare il ruolo del buon arbitro. À partire dagli anni 80, l’unione europea cerca di mostrarsi una « potenza docile », diplomatica e meno guerriera degli Stati Uniti, cercando in questo modo di giocare un ruolo centrale in tutte questioni relative alla condizione climatica.
In ogni modo, la COP é soprattutto il momento in cui tutti i paesi praticano l’arte di eludere il problema in discorsi senza fine. La stragrande maggioranza delle discussioni vertono sempre meno sul contenuto e sempre più sul processo in quanto tale, come la natura stessa dell’accordo che bisognerebbe eventualmente prendere…
In ogni caso, post Kyoto, l’idea di un accordo vincolante, o ancor peggio stipulante delle punizioni, é stato abbandonato. La COP21 dovrebbe privilegiare una forma di partecipazione volontaria senza cifre precise, né vincoli definiti, se non quello dichiarato di mantenere il riscaldamento climatico al di sotto dei 2°C. Tra l’altro, teniamo a precisare che tale cifra, non é assolutamente legata a nessun dato preciso scientificamente parlando. Molte ONG chiedono del resto che tale esigenza venga abbassata a 1,5°C. Il dibattito dei numeri, ridiciamocelo, viene in ogni modo posto esclusivamente sulle emissioni in uscita.
Niente prima del 2030 per la COP21
Il peggio, quando pure la catastrofe é già li, é l’astuzia del lungo termine, il quale permette di discutere di eventuali misure solo a l’orizzonte 2030, per ottenere dei risultati nel 2050…
Il calendario delle decisioni « possibili » della COP21 non cominciano in effetti che nel 2030. La Cina, ad esempio, afferma che, per ragioni di sviluppo, non comincerà a ridurre le emissioni di CO2 che a partire dal 2030, non avanti. Il tutto per avere qualche risultato nel 2050.
In breve, tutto é riportato ad un ipotetico futuro.
Cosa fare ?

« Per salvare i Ghiacciai, lasciamo fondere La Défense. »
Il rapporto di una commissione sul clima del 1987 apriva su questa frase dell’epoca della guerra fredda : « la Terra é una, ma il mondo non lo é ». Da li, non hanno mai smesso di cercare di unirlo, anche solo nei discorsi, cercando di produrre una finzione di umanità unita che prenderebbe in mano il sur destino di salvatrice della Terra.
In realtà, nessun paese vuole adottare una decisione internazionale vincolante, si tratta esclusivamente di una questione d’immagine : « chi si presenta come salvatore di questo mondo ? ».
In pratica, potrebbe verificarsi che fossero tutti attivi, proponendo in un modo o nell’altro, attraverso la geo-ingenieria ed un più forte controllo delle frontiere, delle modalità di gestione delle crisi future e delle forme sempre più precise di governo delle risorse biologiche (come i brevetti, le OGM, ecc). Chi proporrà la neo-soluzione tecnica che permetterà di "gestire" il tutto ?
Chi offrira i suoi servizi alla Polizia ? Diventeranno come gli sbirri di New Orleans dopo Katrina ?
In tale contesto, non é cosi evidente sapere cosa aspettarsi dalla COP, di cui le negoziazioni saranno in ogni modo deludenti, e soprattutto lontane dal vero problema, respingendo per definizione ogni soluzione al 2030 e 2050. In qualche modo, del loro incontro a Parigi o altrove, non possiamo nulla aspettarci, d’altronde meglio che non si lancino troppo nelle loro soluzioni tecniche…Dunque, cosa fare ?
D’innanzi alla COP, bisogna tanto delegittimarla come momento di soluzioni possibili, che impedire direttamente che essa abbia luogo.
Che si tratti di un movimento climatico di grande forza tanto da lasciare i governanti nell’era glaciale ? Come poter negare il legame tra le questioni climatiche e il controllo delle frontiere o delle misure per l’austerità ? Se la soluzione non é strategica, né applicata dalle nazioni unite dai poteri triplicati, a cosa potrebbe sembrare un mondo di territori in lotta ? [2]
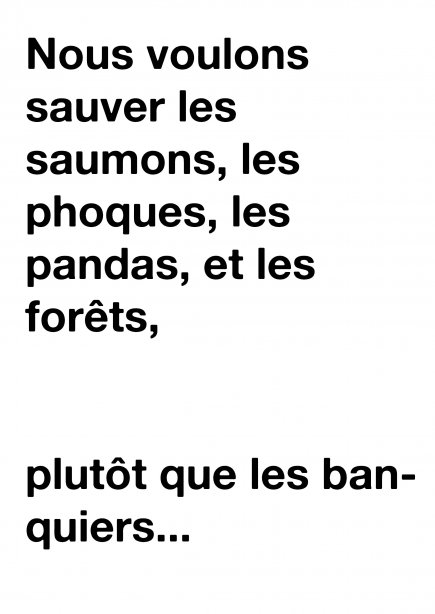
« Vogliamo salvare i salmoni, le foche, i panda e le foreste, piuttosto che i banchieri... »